La dimensione magica della civiltĂ contadina
17.04.2013, Il libro di Aniello Russo (da Il Corriere del 14.4.2013)
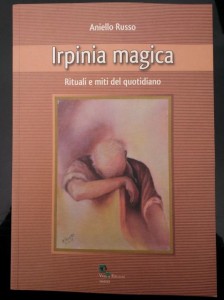 Dopo aver dato alle stampe alcuni testi di narrativa (Il seme del sole, Cunti di Avellino) e altri di linguistica dialettale (Grammatica del dialetto irpino), Russo ha volto il suo interesse al campo dell’antropologia. Nel volume appena edito “Irpinia magica” lo studioso di Bagnoli ricostruisce il contesto esistenziale degli irpini al tempo della civiltà agro-pastorale, avvalendosi di testimonianze dirette che ricreano la dimensione magica del vivere quotidiano di allora.
Dopo aver dato alle stampe alcuni testi di narrativa (Il seme del sole, Cunti di Avellino) e altri di linguistica dialettale (Grammatica del dialetto irpino), Russo ha volto il suo interesse al campo dell’antropologia. Nel volume appena edito “Irpinia magica” lo studioso di Bagnoli ricostruisce il contesto esistenziale degli irpini al tempo della civiltà agro-pastorale, avvalendosi di testimonianze dirette che ricreano la dimensione magica del vivere quotidiano di allora.
Tutto l’arco di vita del contadino e del pastore d’Irpinia, dal concepimento alla nascita e dalla nascita alla morte, era segnato da giorni, da ore e finanche da momenti magici propizi ai sortilegi e alla divinazione. L’elemento irrazionale non poco aiutava a vivere in mezzo agli stenti e alle rinunzie, che affliggevano quotidianamente i nostri nonni, offrendo sia i mezzi per scongiurare i mali sia gli elementi interpretativi dei segni soprannaturali. Nell’opera è narrata una vita intera attraverso le pratiche apotropaiche, le formule propiziatorie, i riti divinatori. Ecco ora dal volume, che è già in libreria, alcuni stralci delle diverse fasi del ciclo esistenziale.
La nascita
Nella società tradizionale le donne, sia che abitassero in paese sia in isolate masserie, davano alla luce i loro piccoli in casa con l’assistenza della levatrice casalinga (mammà na). Per la prima volta la giovane sposa viveva un’esperienza individuale sotto gli occhi di persone estranee. L’evento era gestito da sole donne; in camera, però, con la partoriente entravano solo in quattro: la madre, la suocera, la prima cognata sposata e la mammana.
La suocera e la madre stavano lì ad accogliere il comune nipote, che avrebbe garantito la continuità generazionale dei due casati uniti. Ma l’aspettativa della suocera era ancora più motivata: se femminuccia, la creatura avrebbe portato il suo nome. La presenza della cognata già madre di figli, invece, assumeva un altro significato: essa doveva garantire il vincolo con la partoriente, una volta venuti meno i genitori, sicché i cugini erano chiamati fratelli-cugini e sorelle-cugine. Cancellato il senso di mistero e disdegnata ogni forma di rituale magico, oggi il parto è diventato un evento che si consuma nella solitudine di una fredda sala parto, privo del calore della famiglia e lontano dalla propria comunità .
La fanciullezza
Come l’infanzia, così la prima fanciullezza era in gran parte serena e protetta. Sin dai primi anni i ragazzi vivevano in una dimensione magica. Elementi fortemente connotati di magia sono riscontrabili anche nella narrativa fiabistica di trasmissione orale, di cui avidamente si nutriva e si nutre il ragazzo. A due o tre anni i piccoli cominciavano a stare anche con gli altri bambini, costretti dall’arrivo di un fratellino a cui la mamma doveva riservare maggiore cura.
Allora questi, che erano grandi, si raccoglievano attorno alla nonna o a una zia e ascoltavano dalle sue labbra le storie incantate (li cunti), che parlavano di piccoli personaggi come loro (Fasulillo, Vungulicchio), proiettati nel mondo fascinoso dell’avventura, dove risultavano sempre vincenti, a riscatto delle rinunzie e delle sconfitte del mondo reale.
L’adolescenza
Le femminucce e i maschietti vivevano l’età prepuberale in una promiscuità senza controllo da parte degli adulti. Nella più piccola età essi giocavano nella pace del cortile, per poi affacciarsi al di là del recinto di protezione. Andavano sempre a piedi scalzi come nella polvere della strada, così tra le zolle dei campi. Col passare del tempo, gli incontri tra maschietti e femminucce si facevano più fugaci; e quando accadeva, calava tra l’uno e l’altra l’imbarazzo.
Era cominciata l’età puberale: se stévano mpennà nne (cominciavano a mettere le penne), si diceva con una bella metafora.
Nei maschi l’adolescenza si manifesta con una leggera peluria sul viso, con la modificazione del timbro di voce, che si fa aspra e sgradevole. In una ragazza il segnale dell’età puberale è l’inizio dell’attività mestruale; i fianchi iniziano ad allargarsi, le gambe a farsi sode e tornite, il petto a gonfiarsi, le guance si arrossano. L’evento strappava la bambina ai giochi, catapultandola nel mondo dei grandi. Giungeva così il momento della preoccupazione per l’integrità della fanciulla, perché la verginità era il dono più bello che una ragazza potesse portare come dote allo sposo.
La giovinezza
I primi approcci tra una giovanotto e una ragazza avvenivano in occasioni canoniche, che erano dei veri e propri rituali di fidanzamento. E gli oggetti di cui si avvalevano erano fortemente allusivi: il tappo del barile, il ceppo nella gattaiola, l’arancia lanciata in grembo alla ragazza. A quel tempo era difficile incontrare per strada una ragazza da sola: la potevi vedere in chiesa la domenica oppure al tramonto alla fontana dove andava a prendere l’acqua. Nei pressi della fontana si assiepavano branchi di giovanotti. Sciacquando i panni le donne si chinavano, mostrando inavvedutamente un pezzo di gamba, e agitavano i fianchi, attirando gli sguardi dei giovanotti. Una volta caricato il barile sul capo, si allontanava impettita, caviglie doppie e gambe muscolose; camminava a passo svelto, con la segreta speranza di farsi notare dai giovani.
Tra i più anziani c’è ancora memoria dell’antico rito del fidanzamento con il ceppo. Nella notte il ragazzo poneva un ceppo, tutto adornato di fiori e di nastri, nella gattaiola della porta di casa della ragazza. La mattina, quando la madre dell’amata si alzava e trovava il ceppo, esclamava: “Chi ha messo il ceppo a mia figlia?”. Mostrandosi il ragazzo rispondeva: ”Io, sono stato io!” Se il marito chiamato dalla donna acconsentiva, tirava dentro il ceppo; e il fidanzamento diventava ufficiale. Se no, il ragazzo si rimetteva in spalle il pezzo di legno e se lo riportava a casa.
Il matrimonio
La cerimonia nuziale, che sanciva lo strappo dalla pubertà e l’inizio dell’avventura nel mondo degli adulti, era movimentata da una costellazione di cerimoniali propiziatori che dovevano garantire un favorevole rito di passaggio della donna dallo stato di nubile (zita) a quello di coniugata (mmaretà ta). Il giorno del matrimonio, al fine di confondere chi volesse attivare una fattura, la zita era tenuta a indossare qualcosa di nuovo e qualcosa di vecchio, una cosa avuta in dono e un’altra in prestito e infine un indumento intimo a rovescio.
I banchetti nuziali erano due: il primo si consumava il giorno delle nozze in casa della zita vestita di bianco; il secondo, la domenica appresso, in casa dello sposo con la zita in abito scuro. Tra le due domeniche, la settimana della zita, durante la quale gli sposi non mettevano piede all’esterno. Era il periodo rituale del concepimento. Confinata nella casa del marito, la sposa, chiamata zita solo ancora per questo periodo, non doveva lavorare né contattare altre persone, eccetto la madre e la suocera.
Il divieto di contattare altre persone è giustificato dallo stato di contaminazione della sposa: lo jus primae noctis, che in seguito apparve come un sopruso, inizialmente era ritenuto un atto di grazia ricevuta dal signore del luogo. Il quale, essendo un privilegiato, non era contaminato dalla sposa, che una volta deflorata non poteva più contaminare il marito che aveva successivamente rapporti carnali con lei.
La famiglia patriarcale
La sposa entrava a far parte della famiglia patriarcale di lui, dove occupava l’ultimo posto della scala gerarchica, dopo i suoceri e le cognate già sposate. La famiglia pluricellulare, istituzione risalente al Medioevo, ha resistito fino all’ultimo dopoguerra. Era costituita da tre generazioni e da più nuclei coniugali. Con le nozze restavano in casa solo i figli maschi, mentre le femmine raggiungevano la famiglia dello sposo. La famiglia patriarcale era un gruppo monolitico e garantiva nei lavori una consistente disponibilità di forza lavoro. Nel suo seno trovavano asilo pure i vecchi ormai disabili e i familiari portatori di handicapp. Il vantaggio di vivere assieme era soprattutto economico; separati, avrebbero dovuto accendere quattro cinque fuochi, quattro cinque forni; avrebbero dovuto possedere quattro cinque bestie da soma; e così pure per gli attrezzi di lavoro.
La vecchiaia
Nella società rurale si era vecchi quando la salute non ti sorreggeva più. Ma certamente segnava il corpo dell’uomo molti anni prima di quanto si invecchi oggi. Però, fino a quando si sentiva l’energia nelle gambe e nelle braccia, il vecchio non abbandonava il lavoro, né tantomeno passava ad altri il bastone dell’autorità in famiglia. Il successore era il primo figlio maschio cui era stato imposto il nome del padre del patriarca.
Comunque non erano gli acciacchi a fermare il patriarca: la vista corta, la presbiopia, o la surdìa, l’udito debole. Pure in casa, i vecchi non se ne stavano con le mani in mano: governavano il maiale e le galline, coltivavano l’orto, aggiustavano gli attrezzi; le vecchie continuavano a filare, a rammendare, a sbucciare fagioli; questo d’inverno, accanto al camino. D’estate, sull’uscio di casa. E c’era pure il tempo di spettegolare, sedute in cerchio con le vicine. Le passanti salutavano, e si informavano della salute dei familiari, dei lavori nei campi, del fidanzamento dei nipoti. A sera, i figli trovavano la tavola apparecchiata.
La morte
La morte costituiva un male irrimediabile. Essa rompeva l’equilibrio nella famiglia patriarcale, ingenerando drammatiche espressioni di dolore. Nello stesso tempo turbava la serenità del villaggio, perché la morte non era un evento individuale, ma di tutti. Avere riconosciuto dalla comunità che tutto fosse stato fatto secondo la tradizione pareva essere la preoccupazione del vecchio, che temeva di non essere adeguatamente compianto.
Oggi il funerale è una cerimonia frettolosa, non ha quasi più nulla del complesso rituale tradizionale che coinvolgeva i parenti del defunto e la collettività del paese, assumendo l’aspetto di una manifestazione corale.
Era un atto altamente socializzante che aveva tempi lunghi e complessi rituali. In caso di un evento luttuoso, alla vivacità della vita quotidiana, si sostituiva nella famiglia una tensione drammatica, e nella comunità un’atmosfera di diffuso cordoglio. Saltavano i ritmi di una vita normale, tutto passava in secondo ordine; si rinviava di un anno il matrimonio di un familiare del defunto.
Ogni attività del vicinato si interrompeva; e i ragazzi, ammoniti dagli adulti, rinunziavano per tre giorni ai giochi chiassosi in strada. Un silenzio strano e atipico calava d’improvviso in tutto il quartiere.
Da Irpinia magica di Aniello Russo




























